Le città post Covid saranno il motore del cambiamento verso la transizione ecologica, ma anche verso la democrazia digitale e la partecipazione dei cittadini. Trasformazioni che le amministrazioni locali dovranno attivare grazie alle loro capacità, agilità e prossimità». Per Francesca Bria, presidente del Fondo Innovazione, già assessore all’Innovazione e Digitalizzazione del Comune di Barcellona e senior advisor dell’Onu per le smart cities, «l’Italia ha una grande opportunità con il Recovery plan». Un’occasione che partendo dalla diffusione della banda larga «potrebbe anche favorire un modello di smart city più decentrato che riduca le fratture fra aree metropolitane, borghi e aree interne», regalando quindi un nuovo futuro al Paese.
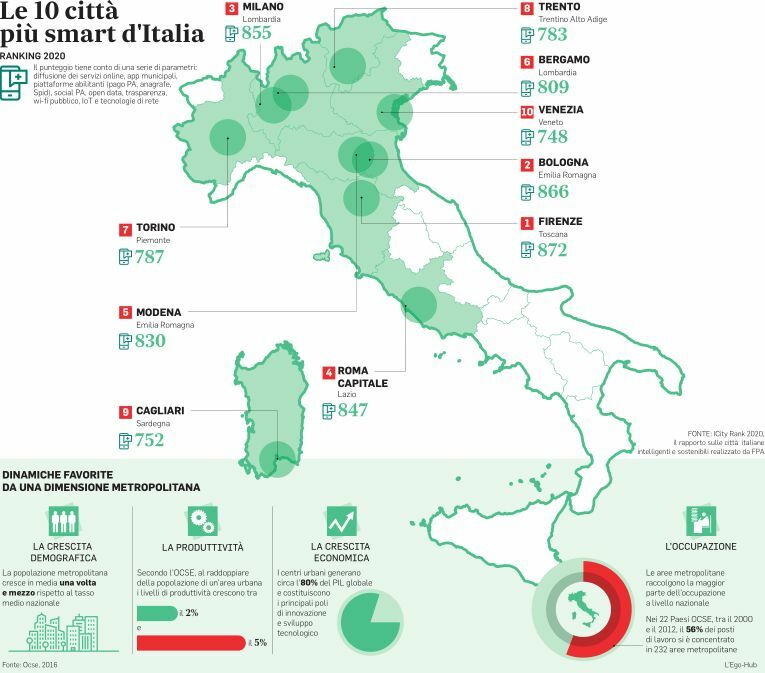
La sindaca Anne Hidalgo: «Parigi smart city, la mia sfida»
Smart city, le province più all'avanguardia delle capitali
Dottoressa Bria, partiamo dal principio. Come dobbiamo intendere una smart city secondo lei? Che vantaggi porta in concreto, al di là dell’idealizzazione?
«Dobbiamo dire chiaramente che una smart city non significa una città iper-tecnologica, ma significa progettare la città del futuro, migliorandola e partendo dai bisogni reali dei cittadini. Direi che la smart city deve combinare tre elementi: primo, la partecipazione democratica dei cittadini (non solo smart city, ma smart citizens, per coinvolgere i cittadini nelle decisioni politiche). Ad esempio a Barcellona abbiamo coinvolto 400mila cittadini nella scrittura del programma della città e il 70% delle azioni politiche è stato deciso da loro attraverso la piattaforma digitale decidim.barcelona. Il secondo tema è la democrazia dei dati che possono aiutare a fare una migliore pianificazione urbana. Ed infine usare l’innovazione per raggiungere la sostenibilità sociale e ambientale: ovvero la transizione verde ed ecologica, l’economia circolare, andando verso città ad emissioni zero che sono più vivibili e quindi più sostenibili. Solo se governata e indirizzata verso questi obiettivi la tecnologia può davvero creare le condizioni per innovare e trasformare le nostre città».
E quali sono invece le criticità? C’è anche una questione etica con cui fare i conti.
«Innanzitutto bisogna rifuggire da ogni forma di soluzionismo tecnologico secondo cui basta una app per risolvere tutti i nostri problemi, come sconfiggere la povertà, il cambiamento climatico o l’invecchiamento. Bisogna invece partire dai problemi reali delle città, come il diritto alla casa, una mobilità sostenibile e connessa, la raccolta efficiente dei rifiuti, la lotta al cambiamento climatico e la transizione energetica e una partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica. Ma è anche necessario saper governare in maniera democratica la tecnologia (dati, connettività, sensori) e metterla al servizio delle persone e del miglioramento della loro qualità di vita».
Tutto passa per i dati quindi.
«Sì e per questo bisogna anche parlare di etica, sicurezza, privacy e controllo democratico dei dati. I dati sono una vera e propria infrastruttura pubblica, come l’elettricità, l’acqua e l’aria che respiriamo, che va gestita per l’interesse pubblico. Serve un patto sociale digitale: il cittadino può riprendere la sovranità e il controllo sui propri dati e condividerli in sicurezza per migliorare i servizi pubblici e prendere migliori decisioni, creando valore pubblico. Di solito quando si parla di società digitale (e lo abbiamo sperimentato in maniera molto chiara durante il Covid) siamo messi di fronte a un doppio scenario: il primo è quello del Big State, il modello cinese top-down e orwelliano in cui lo Stato controlla tutto che, seppur efficace, potrebbe limitare i nostri diritti costituzionali. Il secondo è quello che la professoressa della Harvard Business School Shoshana Zuboff chiama il capitalismo della sorveglianza, che ripone maggiore fiducia nei Big Tech. Anche questo potrebbe funzionare, ma a lungo termine avrà dubbi effetti sulla nostra società. Poi come ho dimostrato nel mio lavoro a Barcellona queste non sono le uniche opzioni. C’è anche una terza via, che è quella della democrazia digitale e di un controllo democratico sui dati da parte dei cittadini e la tecnologia al servizio del bene pubblico».
In Italia invece? A che punto siamo?
«L’Italia ha una grande opportunità con il Recovery plan per connettere tutto il territorio italiano con una rete in fibra ultraveloce, cablando anche aree interne e borghi, Nord e Sud Italia (per aumentarne la penetrazione, oggi al 31% in Italia). La diffusione della banda larga potrebbe anche favorire un modello di smart city più decentrato che riduca le fratture fra aree metropolitane, borghi e aree interne, dando vita a quel modello che Stefano Boeri chiama un arcipelago di borghi connessi e verdi. Oltre alle infrastrutture, bisogna poi creare le capacità nel Paese per valorizzare queste tecnologie e investire nelle persone, nella formazione, in educazione, alfabetizzazione e competenze digitali. L’Italia ha approvato un decreto che stanzia 30 milioni di euro per progetti di riforestazione urbana».
La pandemia e la necessità di digitalizzare le nostre vite stanno recitando un ruolo decisivo per le smart cities? Fanno da catalizzatore?
«La crisi sanitaria sta avendo un effetto inaspettato in alcune città: dovremo anche ripensare gli spazi, il modo in cui lavoriamo, bilanciando il tempo che passiamo a casa e in ufficio, il che significa anche costruire case sostenibili con spazi aperti, giardini urbani e spazi di co-working. Inoltre abbiamo visto una rapida digitalizzazione della società, con la diffusione dello smart working, didattica a distanza, piattaforme per il food delivery, app per il contact tracing e aumento dei pagamenti digitali. Ora dobbiamo rendere questi cambiamenti strutturali e dargli una direzione. Come saranno le città post Covid è quindi una domanda estremamente importante. Le città saranno il motore del cambiamento verso la transizione ecologica, ma anche la democrazia digitale, e la partecipazione dei cittadini. Le amministrazioni locali dovrebbero avere capacità, agilità e prossimità per attivare rapidamente le trasformazioni, per la vicinanza ai problemi reali dei cittadini sono agenti di coesione sociale, tentando con politiche concrete di superare divisioni e disuguaglianze. Dobbiamo crederci e dotarle di capacità e di risorse umane e finanziarie».
Che cosa manca a Roma per essere città smart?
«Le priorità mi sembrano chiare: investire in mobilità connessa e sostenibile, garantire a tutti il diritto alla casa, raccolta efficiente dei rifiuti, lotta al cambiamento climatico, diventare un hub europeo di scienza, tecnologia, arte e cultura e tornare ad essere una vera Capitale europea con proposte innovative sul futuro, che allo stesso tempo migliorino chiaramente la vita dei cittadini. Soprattutto bisogna investire sulle competenze e il talento delle persone, a partire dall’amministrazione pubblica. Una smart city è solo possibile grazie a una burocrazia smart. Serve attrarre giovani di talento per trasformare l’amministrazione da dentro. A Barcellona ho assunto 65 persone, la maggior parte giovani appena usciti dalle università e con nuove skills. Ho creato un team di analisi dei dati di 40 persone. Ho investito in formazione e ho scommesso su un cambio organizzativo e culturale. È difficile, ma la mia esperienza dimostra che si può fare. Roma può partire dalla sua storia, dalla sua cultura millenaria e trasformarsi verso il futuro. Ci serve un rinascimento digitale, un umanesimo tecnologico, che metta al centro le persone e non crei nuove diseguaglianze. Chi può farlo meglio delle città italiane che sono la culla del primo Rinascimento?».
